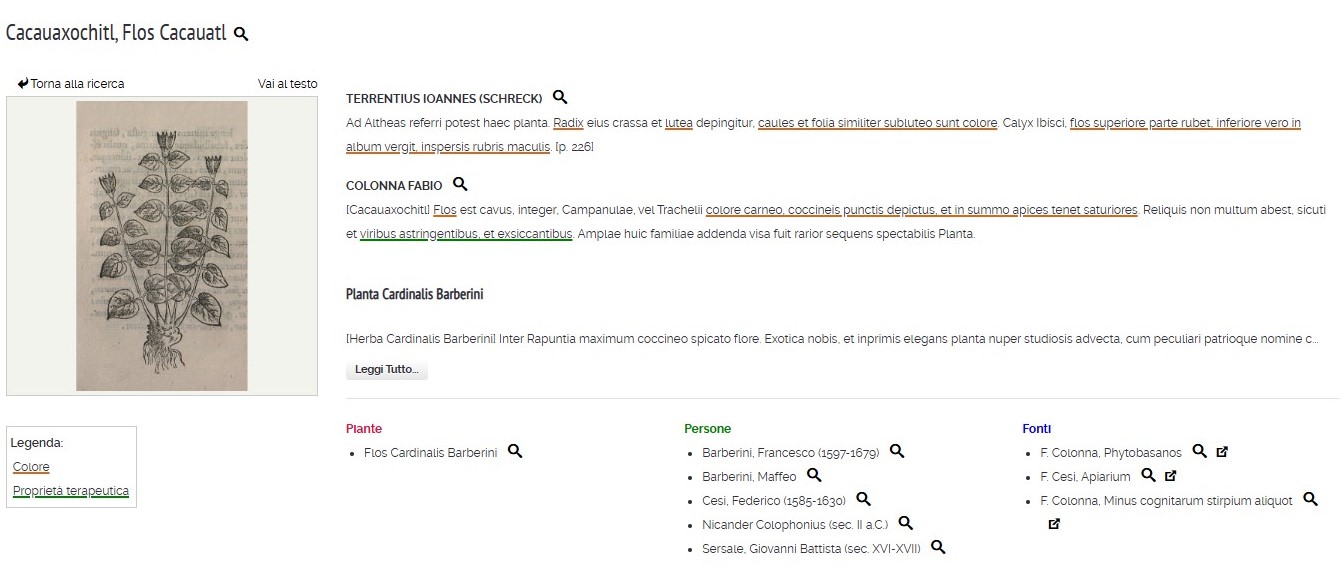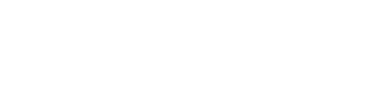La bibliografia indicata è essenziale; alle fonti effettivamente utilizzate dai commentatori lincei è affiancata una selezione di studi utili ad un primo inquadramento di carattere storico-critico dell’opera.
FONTI
Alpini, Prospero. De plantis exoticis libri duo
Alpini, Prospero. Prosperi Alpini De plantis Aegypti liber
Avicenna. Liber canonis medicine
Bauhin, Caspar. Phytopinax seu Enumeratio plantarum
Besler, Basilius. Hortus Eystettensis
Camerarius, Joachim. Hortus medicus et philosophicus
Cesi, Federico. Apiarium
Cieza de León, Pedro. Historia Peruana
Clusius, Carolus. Exoticorum libri decem
Clusius, Carolus. Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia
Clusius, Carolus. Rariorum Plantarum historia
Colonna, Fabio. Minus cognitarum stirpium aliquot
Colonna, Fabio. Phytobasanos sive Plantarum aliquot historia
Dalechamps, Jacques. Historia generalis plantarum
Della Porta, Giovan Battista. Magiae naturalis libri XX
Falloppio, Gabriele. De morbo Gallico
Fernández de Oviedo, Gonzalo.Historia general y natural de las Indias
Grill, Lorenz. De Sapore dulci et amaro
Hernández, Francisco. Francisci Hernandi ... Opera : cum edita, tum inedita, ad autographi fidem et integritatem expressa, impensa et jussu regioImperato, Ferrante. Historia naturale
Lobel, Mathias de. Plantarum, seu, Stirpium historia
Mattioli, Pietro Andrea. Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De medica materia
Mattioli, Pietro Andrea. De plantis epitome utilissima
Mattioli, Pietro Andrea. Petri Andreae Matthioli Opera quae extant omnia
Pona, Giovanni. Monte Baldo descritto da Giovanni Pona veronese
Scaligero, Giulio Cesare. Iulii Caesaris Scaligeri Exotericarum exercitationum lib. XV
STUDI
Antei, Giorgio. Tesoro Mexicano : visioni della natura fra Vecchio e Nuovo MondoBaldriga, Irene. L'occhio della lince : i primi Lincei tra arte, scienza e collezionismo (1603-1630)
Brevaglieri, Sabina. Natural desiderio di sapere
Cadeddu, Maria Eugenia e Guardo, Marco. Il Tesoro messicano: libri e saperi tra Europa e Nuovo Mondo
Camerota Michele, Ottaviani Alessandro, Trabucco Oreste. Lynceorum historia: le schede lincee di Martin Fogel
Freedberg, David. The eye of the lynx: Galileo, his friends and the beginnings of modern natural history
Gabrieli, Giuseppe. Il carteggio linceo
Gabrieli, Giuseppe. Contributi alla storia della Accademia dei Lincei
Galluzzi, Paolo. Libertà di filosofare in naturalibus: i mondi paralleli di Cesi e Galileo
Graniti, Antonio [a cura di]. Federico Cesi : un principe naturalista : Acquasparta, 29 e 30 settembre 2003
Guerrini, Luigi. The Accademia dei Lincei and the New World
Guerrini, Luigi. Piante e animali nel Nuovo Mondo : Federico Cesi e il Tesoro Messicano
Marini Bettòlo, Giovanni Battista. La collaborazione scientifica tra Italia e Spagna per la conoscenza delle risorse naturali del Nuovo MondoMarini Bettòlo, Giovanni Battista e Salvini, Giorgio [prefazione]. Una guida alla lettura del tesoro messicano : Rerum medicarum novae Hispaniae thesaurus
Olmi, Giuseppe. L'inventario del mondo : catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna
Ottaviani, Alessandro. Da Fabio Colonna a Paolo Boccone : momenti della storia della botanica fra Napoli e Sicilia (con un appendice di lettere inedite)
Ottaviani, Alessandro. La parte di Fabio Colonna nel Tesoro messicano dei Lincei
Ottaviani, Alessandro. Natura ed esattezza all'alba della scienza galileiana : le Observationes di Fabio Colonna
Ottaviani, Alessandro. La natura senza inventario: aspetti della ricerca naturalistica del linceo Fabio Colonna
Ottaviani, Alessandro e Trabucco, Oreste. Theatrum naturae: la ricerca naturalistica tra erudizione e nuova scienza nell'Italia del primo Seicento
Tongiorgi Tomasi, Lucia e Tongiorgi, Paolo. La nascita della moderna iconografia botanica
Le brevi biografie qui riportate sono tratte da: G.B. Marini Bettòlo; prefazione di Giorgio Salvini, Una guida alla lettura del tesoro messicano.
La resa delle immagini, ottenute (a costi elevatissimi) attraverso la tecnica xilografica, non fu – come apparve subito evidente a Cesi e ai sodali lincei – propriamente soddisfacente, soprattutto se paragonata alle eccellenti riproduzioni che figuravano in testi botanici coevi, come l’Hortus Eystettensis di Basilius Besler (1613). Alla scarsa definizione dei contorni e dei dettagli si aggiungeva l’assenza, nella stampa, dei colori, ben presenti nella copia di Recchi. Appariva così di fondamentale importanza, per i commentatori lincei, sopperire a questa evidente lacuna col fornire precise indicazioni e informazioni circa l’aspetto degli esemplari provenienti dal Nuovo mondo, restituendone – attraverso il ricorso a similitudini con oggetti appartenenti al Vecchio – odori, sapori, sensazioni tattili di vario genere. Una necessità tutt’altro che trascurabile in particolare per la sezione botanica – in assoluto la più consistente: circa 830 immagini, se comprendiamo i particolari singolarmente raffigurati – dove occorreva incoraggiare il lettore a procedere oltre l’impressione fornita dalla ‘nuda figura’ in bianco e nero, affiancandole, ove possibile, una puntuale ‘colorum descriptio’ delle sue varie componenti: fiori, semi, foglie, radici, ecc. (cfr. Schreck, Aliarum novae hispaniae plantarum, p. 346).