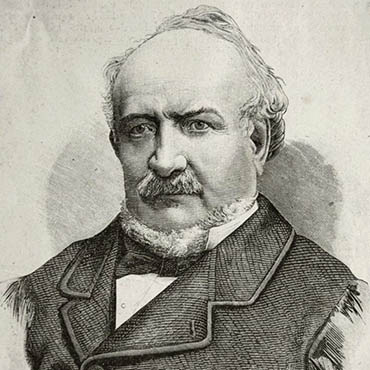Nato nel 1820 a Cumiana presso Torino, studiò al collegio di Carmagnola, dove ebbe fra i docenti il sacerdote rosminiano Giovanni Antonio Rayneri. Frequentò poi l’università a Torino, venendo così in contatto con gli ambienti del moderatismo neoguelfo, come il salotto di Luigi Ornato. Dopo la laurea in filosofia e filologia si interessò ai metodi educativi per l’istruzione elementare, e nel 1846 si diplomò alla Scuola superiore di metodo normale inaugurata da Ferrante Aporti sotto il regno di Carlo Alberto di Savoia. L’anno successivo, dopo una breve esperienza di insegnamento nelle scuole, fu professore incaricato di metodo applicato all’istruzione elementare presso l’Università di Torino, impegnato a formare delle guide che avrebbero dovuto porre i mattoni fondanti per la formazione di una coscienza nazionale.
Attivo politicamente prima fra i democratici di Lorenzo Valerio, poi fra i cattolici moderati e infine fra i liberali moderati, collaborò con vari periodici dei diversi orientamenti. Ottenuta nel 1849 la cattedra di filosofia morale, diede il via a un ambizioso progetto di studio sulla storia del pensiero italiano con lavori documentati su Giordano Bruno e Pico della Mirandola, senza trascurare il tema della pubblica istruzione, sempre al centro dei suoi interessi, fino a promuovere la fondazione a Torino della Libreria metodica per l’istruzione ed educazione gratuita del popolo, patrocinata da Cesare Alfieri, Terenzio Mamiani e Pasquale Stanislao Mancini, e di vari istituti di diffusione della cultura nazionale.
Nel 1850 fu eletto deputato, ma non condividendo la politica sull’istruzione del secondo governo Cavour, che a suo avviso ledeva la libertà di insegnamento delle scuole private, si allontanò dalla destra giocandosi l’elezione alla VI legislatura in una nuova formazione politica e rientrando in parlamento solo nel 1860. I numerosi incarichi che gli furono conferiti, fra il Consiglio di Stato e il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, lo costrinsero ad abbandonare la cattedra all’Università di Torino. Nominato ministro della Pubblica Istruzione nel 1865, si adoperò per il contrasto all’analfabetismo e per la fondazione di biblioteche ad uso degli insegnanti.
Terminato l’incarico, si dedicò agli studi pubblicando la Vita di Giordano Bruno (1868), che diede inizio a una serie di lavori su Bruno e Campanella, ma soprattutto sulle fonti manoscritte della storia del copernicanesimo in Italia e delle vicende inquisitoriali ad esso legate, fra cui si ricordano in particolare il volume Copernico e le vicende del sistema copernicano in Italia nella seconda metà del sec. XVI e nella prima del XVII, con documenti inediti intorno a G. Bruno e G. Galilei (1876) nato da un ciclo di lezioni affidategli in occasione dei 400 anni dalla nascita di Copernico, e Il processo originale di Galileo Galilei (1878). Politicamente sempre più tendente verso la sinistra, fu ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio nel quarto e quinto governo Depretis. Ma il suo programma, enunciato in alcuni scritti con l’intento pur timido di porre le basi per garantire regolamentazioni e tutele per il mondo del lavoro, non trovò per motivi opposti né l’appoggio della destra, né del movimento operaio, e fu fatto fallire costringendolo a cedere l’incarico. Sempre meno coinvolto nella politica forse per l’affievolirsi di quelle spinte risorgimentali che come oggetto di studio continuò a tener vive lungo tutto l’arco della sua vita, ebbe varie cariche onorifiche e sedette in parlamento fino alla morte avvenuta a Roma nel 1897.
La conoscenza di Antonio Favaro col Berti era stata precoce e risaliva all’ammirata recensione a Copernico e le vicende del sistema copernicano in Italia che Favaro, allora giovane professore, pubblicò sulla «Zeitschrift für Mathematik und Physik» di Lipsia e amò sempre considerare il suo primo scritto di argomento galileiano. Quasi fanatico delle ricostruzioni documentate cui si dedicava maniacalmente e ben oltre lo spirito dei tempi, persuaso che quel rinnovamento cattolico che auspicava, e che lo vide tenace sostenitore della legge delle guarentigie, dovesse passare dal riconoscimento dell’errore capitale compiuto dalla Chiesa contro Galileo, il Berti fu fra i primi a spingere Antonio Favaro a concentrarsi sugli studi galileiani: «in un tempo nel quale io andava ancora ondeggiando dall’uno all’altro argomento di storia scientifica –riconosceva il Favaro commentando alla Crusca la pubblicazione dell’ultimo volume dell’edizione nazionale –, mi confortò a convergere sopra l’altissimo soggetto di tutti i miei studii». Tuttavia, al di là delle retoriche celebrative sulle personalità di spicco, il Berti fu in seguito quasi un ostacolo all’avvio dei lavori, vedendo «assai di mal occhio» che qualcun altro si accingesse a un’impresa che lui stesso aveva aspirato a condurre e nella quale non si trovava coinvolto. Quando, nel febbraio del 1887, l’ennesimo rinvio della pubblicazione del decreto che doveva ufficializzare il battesimo del progetto era stato imputato alla recente disfatta di Dogali, scrivendo a Isidoro Del Lungo, il Favaro, più che la responsabilità del «Ras Alula dell’Abissinia», subodorava lo zampino di «qualche altro Ras» a loro più vicino, del quale non c’era alcun bisogno di esplicitare il nome.