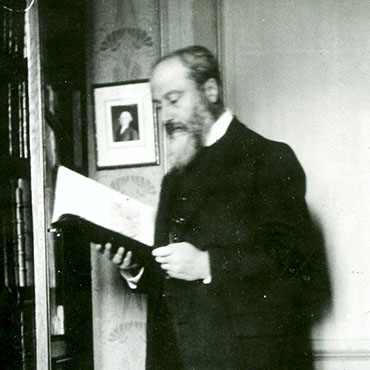Nacque a Parigi nel 1861 da un padre di origini fiamminghe impiegato nel settore tessile e da una madre di ascendenze borghesi. Istruito privatamente durante un’infanzia funestata dalle vicende della guerra franco-prussiana che costrinse la famiglia a sfollare a Bordeaux, al rientro a Parigi visse i mesi della Comune in un clima di indignazione, per via dell’avversione dei Duhem, cresciuti in un rigida educazione religiosa, verso le divaricazioni fra Stato e Chiesa, la laicizzazione delle scuole, la nazionalizzazione di beni ecclesiastici, la violazione dei territori consacrati.
Nonostante la tragedia familiare della morte per difterite di un fratello e di una sorella, dal 1872 Pierre Duhem proseguì gli studi al Collège Stanislas, istituto di tradizione cattolica, dove dichiarerà lui stesso di aver appreso le basi teoriche e critiche dal fisico Jules Moutier, i cui studi di termodinamica furono il primo gradino di importanti sviluppi futuri. Nel 1882 si iscrisse alla École normale supérieure, dove fu sempre il primo della classe, fino alle lauree in matematica e in fisica. La sua passione per la fisica teorica, oltre a fargli rifiutare un posto di chimico batteriologo offertogli subito dopo la laurea, lo spinse a tentare la carriera accademica, ma la sua tesi dottorale su Le potentiel thermodynamique et ses applications à la mécanique chimique et à l’étude des phénomènes électriques fu bocciata da una commissione composta dal fisico Gabriel Lippmann e dai matematici Charles Hermite ed Émile Picard. Sulla decisione pare avessero avuto un peso le divergenze politiche di commissari laici e anticlericali verso un candidato cattolico conservatore, rigido e incline alla polemica, e l’odio accademico dovuto alla confutazione nella tesi del principio di Thomsen-Berthelot sulla produzione di calore nei cambiamenti chimici: Marcellin Berthelot, amico di Lippmann, avrebbe posto addirittura un veto sull’ammissione di Duhem fra i docenti parigini, confinandolo a vita fuori dalla propria città natale. Più avanti negli anni Duhem avrebbe rifiutato una cattedra di storia della scienza al Collège de France, dichiarando che sarebbe tornato a Parigi solo come professore di fisica teorica, il che non avvenne mai.
Nonostante tutto, le Éditions Hermann decisero di pubblicare ugualmente la sua tesi, e una seconda commissione formata dal fisico Edmond Bouty, dal matematico Gaston Darboux e da Henri Poincaré lo avrebbe addottorato nel 1888 grazie a una tesi sull’induzione magnetica. Già dall’anno precedente Duhem era maître de conférences a Lille, ma nonostante la nutrita produzione di studi su idrodinamica, elasticità e acustica, su elettricità e magnetismo e sulla chimica fisica, a causa di screzi nati per futili motivi, si trasferì prima a Rennes e poi, dal 1894, a Bordeaux.
Parallelamente alle sue ricerche principali, alimentate dalla convinzione di una termodinamica generalizzata come fondamento della teoria fisica e confluite poi nel Traité d’énergétique ou de thermodynamique générale del 1911, Duhem si dedicò a questioni di carattere metodologico e a lavori storico-scientifici. Nati probabilmente come funzionali a difendere i suoi principi di fisica teorica, i suoi studi di filosofia e storia della scienza divennero col tempo filoni indipendenti d’indagine. Le sue pubblicazioni di carattere epistemologico, prima fra tutte La théorie physique, son objet et sa structure del 1906, nel definire il limiti del metodo scientifico, i rapporti fra fenomeno e teoria fisica, il ruolo e le prerogative del fisico teorico, si valevano di argomentazioni di tipo storico, che sfociarono in un’imponente campagna di ricerca documentaria concretizzata poi in volumi come Les origines de la statique (1905-1906), le Études sur Léonard de Vinci, ceux qu’il a lus, ceux qui l’ont lu (1906-1913), ΣΟΖΕΙΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée (1908) o Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic (1914-1954), progettato in dodici volumi e lasciato incompiuto.
La tesi di fondo che sottendeva alla produzione storica di Duhem era quella di un filo ininterrotto fra la scienza del tardo medioevo e il pensiero scientifico moderno, da Leonardo da Vinci, influenzato da Giordano Nemorario e la sua scuola, a Galileo e la sua dinamica, direttamente discendente dalle teorie dell’impetus di Giovanni Buridano e Nicola d’Oresme. Sintetizzava limpidamente il Favaro le posizioni del collega: «lo sviluppo scientifico è soggetto alla legge di continuità; […] le grandi scoperte sono quasi sempre il frutto d’una preparazione lenta e complicata, proseguita attraverso i secoli; […] le dottrine, le quali i più insigni pensatori giunsero a professare, risultano da una moltitudine di sforzi accumulati da una folla di oscuri lavoratori. Cosicché né Galileo, né Descartes, né Newton sarebbero riusciti a formulare una qualsiasi dottrina la quale non si connetta per mezzo di legami innumerevoli agli insegnamenti di coloro che li hanno preceduti».
L’impostazione e le analisi di Duhem non godettero di buona stampa fra i colleghi, tanto meno in Italia. Lo stesso Favaro si sentì costretto a scrivere una nota su Galileo Galilei e i Doctores Parisienses (1918), per ricacciare gli Juvenilia galileiani nel loro ruolo di quaderno scolastico e non di testo teorico meditato, dimostrando così documenti alla mano come «l’argomento principale portato contro» l’oggetto sempiterno dei suoi studi fosse «del tutto destituito di valore». E ribadendo «il grande precetto che negli studi critici sulla storia delle scienze è mestieri guardarsi dall’attribuire ad autori non moderni quelle che a noi sembrano conclusioni immediate delle premesse che essi enunciano, o premesse necessarie delle conclusioni alle quali essi pervengono». Tuttavia, nonostante le critiche, il Favaro riconobbe a Duhem grandi meriti per «qualità dell’ingegno», «solidità della dottrina», «vastità dell’erudizione» e «rigoroso metodo di indagine scientifica». La mole dei suoi contributi era tale «da far credere che un solo uomo non bastasse a tanto, e da lasciar supporre ch’essa fosse il frutto dell’attività di più studiosi dallo stesso nome».
E al di là dei dissensi, per le indubbie capacità nel ricorso a fonti inesplorate e per l’originalità delle indagini, Antonio Favaro vide in Duhem «quasi il solo rapresentante» degli studi storico-scientifici in Francia dopo la morte di Paul Tannery, e non meno un prezioso collaboratore per le proprie ricerche, come dimostrano anche le notizie biografiche di personaggi pressoché ignoti, raccolte dietro sua richiesta e conservate fra gli autografi del suo archivio. Pierre Duhem morì prematuramente a Cabrespine nel 1916.