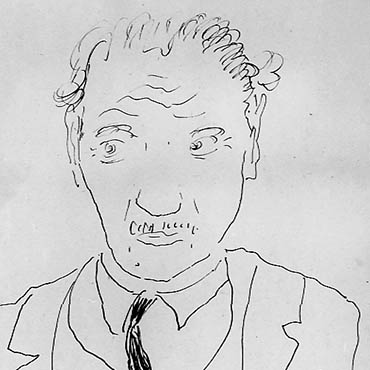Figlio di proprietari terrieri, nacque a Tortorici, provincia di Messina, nel 1888. Frequentò il ginnasio di Patti, sempre in provincia di Messina, si diplomò al liceo classico di Acireale, per iscriversi poi alla facoltà di Fisica dell’Università di Napoli, dove insegnavano Michele Cantone, Roberto Marcolongo e Francesco Giacomo Tricomi. Da sempre attratto dai problemi filosofici, fu in corrispondenza fin da giovanissimo con Benedetto Croce e, soprattutto, col suo conterraneo Giovanni Gentile, e iniziò precoci collaborazioni a riviste culturali. Compiuto il biennio, si trasferì all’Università di Bologna per laurearsi nel 1920, dopo aver studiato con personalità come Giacomo Ciamician, Luigi Donati, Federigo Enriques e Augusto Righi.
La riflessione sulle relazioni fra filosofia, scienza e storia lo assorbì al punto di partecipare nel 1914 alla fondazione della rivista «L’arduo», nata per aprire una discussione su questi temi, ma presto cessata. Solo dopo la prima guerra mondiale, nella quale combatté riportando anche alcune ferite, Timpanaro riuscì a riprenderne la pubblicazione, partecipando con alcuni contributi, fino alla chiusura definitiva nel 1923. L’anno successivo fu incaricato e direttore dell’Istituto di fisica all’Università di Parma, dopo aver ricoperto i ruoli di assistente e aiuto, ma non avendo giurato fedeltà al fascismo approfittando di un’aspettativa per malattia, nel 1928 non fu confermato in ruolo e licenziato.
Trasferitosi ad Arezzo, visse di lezioni private e ricoprì alcuni insegnamenti senza stipendio. Collaborò a numerose riviste di rilievo, spesso con contributi di carattere storico, e pubblicò due antologie di scritti galileiani e leonardiani. Entrato nel circolo fiorentino che faceva capo alla rivista «Solaria» fu in amicizia con gli artisti e gli scrittori più importanti dell’epoca, da Eugenio Montale a Salvatore Quasimodo, da Elio Vittorini ad Alessandro Bonsanti, da Giorgio Morandi a Ottone Rosai. Non sarà stata estranea a queste frequentazioni la sua passione di collezionista che diede luogo a una notevole raccolta d’arte, lasciata in morte all’Università di Pisa. I lavori di interesse storico-scientifico che Timpanaro aveva pubblicato (compresi due volumi di opere di Galileo stampati con Rizzoli fra il 1936 e il 1938), oltre probabilmente alla stima reciproca che aveva tenuto vivo quel rapporto epistolare inaugurato in gioventù, convinsero Giovanni Gentile ad affidargli la pianificazione, e in seguito la direzione, della Domus Galilaeana, istituita a Pisa nei primi anni Quaranta.
Oltre a promuovere riviste e collane di storia della scienza, contribuendo lui stesso con numerosi articoli su Galileo e sui maggiori scienziati italiani, Timpanaro fu particolarmente attivo nell’incrementare il patrimonio di libri e manoscritti depositato alla biblioteca dell’istituto da lui diretto. Fu grazie alla sua tenacia che l’archivio e la biblioteca di Antonio Favaro furono inglobati fra i fondi della Domus, superando prima una certa ritrosia del figlio Giuseppe Favaro e poi una serie infinita di traversie dovute alle vicende belliche. Più volte, nelle lettere a Gentile come nei suoi lavori, Timpanaro aveva sottolineato l’importanza dell’opera di Antonio Favaro, non solo per gli studi galileiani, ma per la metodologia degli studi storico-scientifici e, più in generale, per la propria idea di un sapere unitario fatto di filosofia, scienza e letteratura, che vedeva nel rigore dell’indagine storica uno dei principali strumenti di comprensione. Sebastiano Timpanaro senior morì a Pisa nel 1949. Aveva sposato Maria Cardini, scegliendo di dare il suo stesso nome al figlio Sebastiano Timpanaro, grande filologo e intellettuale del secondo Novecento.