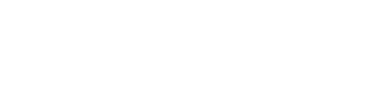Le brevi biografie qui riportate sono tratte da: G.B. Marini Bettòlo; prefazione di Giorgio Salvini, Una guida alla lettura del tesoro messicano.
Duca di Acquasparta e principe di Sant'Angelo e di Monticelli (oggi Montecelio) è il principale realizzatore della stampa della documentazione botanica, zoologica e mineralogica raccolta nel Messico da Francisco Hernàndez. Scienziato, umanista, mecenate, è una delle figure più importanti della scienza del XVII secolo, oggi ancora troppo dimenticata e insufficientemente valutata. La fondazione dell'Accademia dei Lincei, a lui dovuta, rappresenta una profonda innovazione nella cultura del suo tempo che Egli schiude ad una nuova scienza basata sull'osservazione della natura e dei fenomeni naturali in opposizione alle scuole dell'epoca.
Nato nel 1585, dalla nobile famiglia romana dei Cesi, duchi di Acquasparta, studioso di scienze naturali ed in particolare della botanica, si circondò nella sua Accademia di giovani studiosi italiani e stranieri, promuovendo studi e ricerche per le quali richiedeva grande spirito di osservazione. L'osservazione doveva essere molto acuta così che la lince, nota per la sua acutezza visiva, fu presa come simbolo del cenacolo Linceo.
Cesi si impegnò in vari campi delle scienze naturali con l'intento di riunire le sue osservazioni in un'opera monumentale da intitolare Theatrum totius naturae. Di grande rilievo sono le cosiddette Tabulae phytosophicae che rappresentano un importante tentativo di sistematica botanica, nel quale egli aveva incluso anche le piante del Nuovo Mondo. Questa opera riporta anche molte importanti osservazioni, come la scoperta del doppio sesso delle piante ad altre sulle piante eliotropiche.
Il suo primo biografo, l'Allacci, riporta una sua prima bibliografia nel 1633. Cesi contribuì alla impostazione ed alla redazione del Rerum Medicarmi Novae Hispaniae Thesaurus e scrisse una opera sulle Piante imperfette, funghi ed altre piante senza fiori, con l'Eckio, opera considerata perduta e recentemente riscoperta a Parigi.
Cesi ebbe il merito di introdurre nella ricerca botanica l'uso dell'«occhialino», lo strumento che egli denominò microscopio, come pure di proporre per il canocchiale il nome di telescopio, Nomen Telescopii excogitavit, scrive lo Stelluti.
Cesi non riuscì a terminare le sue opere per la sua morte prematura nel 1630 e gran parte del suo lavoro è andato disperso.
Federico Cesi, era uomo di profonda cultura e pieno di interessi. Il suo «naturai desiderio di sapere» non si limitava al lavoro sperimentale, si circondava di libri anche scritti in arabo che potessero soddisfare la sua curiosità scientifica.
Nobile di Fabriano, entusiasta della osservazione della natura fu insieme a Federico Cesi, Giovanni van Heeck, l'Eckio, medico olandese, e ad Anastasio de Filiis di Terni, uno dei fondatori nel 1603 dell'Accademia dei Lincei. Solerte, attivo, discreto, è stato sempre l'anima dell'Accademia, seguendone il lavoro, vivente Federico Cesi, e quindi prendendone la pesante eredità, nel travagliato periodo del processo a Galileo.
Egli aveva pubblicato un magnifico volume delle sue ricerche sulle Api — L'Apiario — e aveva collaborato alla Melissografia, opere edite dai Lincei — che hanno il merito di portare anche qui per la prima volta figure eseguite osservando i dettagli anatomici dell'Ape con il nuovo strumento ottico, il microscopio.
Stelluti per dare compimento al Tesoro ne compilò i magnifici indici e fece stampare le sette ultime Tavole fitosofiche, sia pure incompiute, lasciate da Federico Cesi.
Con questo ultimo impegno nel 1651 si può considerare che si dissolva la comunità Lincea.
Lo Stelluti morì a Roma nel 1653.
Nato a Torino nel 1590 fu uno studioso e scienziato eclettico ed umanista.
Venuto a Roma, fu molto vicino al Cardinale Francesco Barberini, nipote del Papa Urbano Vili, di cui divenne il segretario.
Egli lo seguì tra l'altro in Spagna nel 1626 quando il Cardinale vi si recò come nunzio. In quella occasione, ottenne dal bibliotecario dell'Escoriai, una copia del manoscritto Heraandino, da cui trasse il Liber Unicus, che appare negli esemplari del Tesoro dopo il 1648.
Dal Pozzo ascritto ai Lincei nel 1622 ebbe il grande merito di raccogliere uno straordinario materiale bibliografico di grande interesse storico, e soprattutto di acquistare gran parte dei libri della biblioteca di Federico Cesi, dopo la sua morte per evitarne la dispersione. Morì nel 1657.
Johannes Schreck che latinizzò il suo nome in Johannes Terrentius è l'altro commentatore del compendio di Recchi. Nato a Costanza in Germania, venne a Roma dove acquistò fama per le sue conoscenze botaniche. Il Proja lo definisce «celebre fisico e medico». Nel 1611 fu ascritto tra i Soci Lincei e in questo anno si dedicò intensamente al commento del compendio di Recchi ed anche alla descrizione di alcune piante riportate solo sommariamente dal Recchi.
La partecipazione di Terrentio al cenacolo Linceo fu purtroppo molto breve, in quanto entrando nel 1612 nella Compagnia di Gesù, per lo statuto linceo fu costretto a lasciare l'Accademia. Il suo interesse per il Tesoro si continuò a manifestare ancora dopo avere lasciata l'Accademia. Durante il suo viaggio in Spagna nel 1618 gli fu possibile controllare il manoscritto dell'Hernàndez.
Nel 1618 partì per la Cina come missionario e per partecipare agli studi per la riforma del calendario cinese che l'Imperatore aveva affidato ad un gruppo di padri gesuiti.
In Cina raccolse numeroso ed importante materiale, oggi ancora in parte inedito o purtroppo disperso. Alcune opere matematiche di questo periodo furono pubblicate a Pechino con il suo nome, questa volta in lingua cinese, di Theng Yu-han. Morì nel 1630.
Altro Linceo che partecipò indirettamente alla opera del Tesoro è Giusto Ricchio, o Josse de Rycke, latinizzato in Justus Riquìus, scienziato belga, grande amico del Faber che più volte lo menziona e gli dedica anche un sonetto stampato nel testo del Tesoro. Al Ricchio molto colto in archeologia e in lettere latine, fu affidata la revisione linguistica del testo latino del Tesoro.
Johannes Faber è il nome latinizzato di Johannes Schmidt, medico e scienziato tedesco nato a Bamberga nel 1577. Egli studiò a Roma alla Sapienza e fu discepolo del Cesalpino. Primario medico all'Ospedale del Santo Spirito e curatore del Giardino dei Semplici. Professore alla Sapienza, fu uomo di grande sapere e di grande attività. La sua fama lo mise a contatto con tutti i principali studiosi e anche uomini di stato della sua epoca, come risulta dallo straordinario carteggio lasciato alla Chiesa di Santa Maria in Aquiro in Roma ed ora depositato presso l'Accademia dei Lincei, costituito da 14 volumi di lettere in latino, tedesco ed italiano.
Il Faber nei suoi scritti si definisce filosofo, medico e « pubblico professore romano » — cioè professore della Sapienza, curatore delle piante del Sommo Pontefice nell'orto botanico che allora si trovava in Vaticano.
Il Faber è uno scienziato che vive profondamente la vita sociale del suo tempo; ha rapporti e relazioni con le maggiori personalità della Corte Pontificia oltre che del mondo scientifico europeo. Egli si dedica nel quadro dell'opera collettiva lincea a commentare gli animali del Messico riportati dal Recchi. Scrive così un vero trattato, un volume in quarto di circa quattrocento pagine.
La sua cultura non si limita alle scienze naturali ma è vastissima e tocca i campi della storia e dell'archeologia, della geografia.
Johannes Faber muore nel 1629 a Roma.
Fabio Colonna nato a Napoli nel 1567, acquistò per i suoi studi fama di naturalista ma soprattutto di botanico. Egli per la sua scienza si afferma in un più vasto contesto europeo. Quale botanico ebbe contatti con tutti i botanici del suo tempo. Ha lasciato importanti opere botaniche e naturalistiche come il Phytobasanos e Minus cognitarum rariorumque species.
La sua fama è soprattutto legata al fatto che egli propose per la classificazione delle piante il termine genere. Linneo un secolo dopo lo definiva il più grande botanico dei suoi tempi: «Omnium botanicorum primus» (Linné, Amoenitates academ., III, Holmiae 1750, p. 80).
Fu molto amico di Federico Cesi che aveva conosciuto a Napoli e fu ascritto tra i Lincei nel 1612.
La sua partecipazione, per cui era stato sollecitato dal Cesi al commento e alla revisione del Compendio di Recchi, è limitata ma molto precisa e profonda ed è un esempio della evoluzione del mondo botanico, basato sull'osservazione, rispetto all'impostazione classica di Teofrasto e di Plinio
Colonna introduce in questi commenti «più filosofia e verità». Morì a Napoli nel 1640.
Francisco Hernàndez era nato a Puebla de Montalbàn in provincia di Toledo nel 1515. Si addottorò in medicina presso l'Università di Alcala de Henares. Esercitò la professione in varie parti della Spagna e particolarmente a Siviglia, dove approfondì le sue conoscenze nel campo della botanica. Trasferitosi a Toledo e poi a Madrid, entrò in contatto con illustri medici del suo tempo come il Vesalio, e si dedicò anche a tradurre in «castigliano» la Historia naturalis di Plinio, dimostrando una notevole cultura scientifica.
Venne nel 1569 a fare parte della corte come medico di camera di Filippo II che, apprezzandone le qualità, lo nominò nel 1570, Protomedico delle Indie, con l'incarico di recarsi nella Nuova Spagna, cioè nel Messico, per studiare la Storia naturale medica del Nuovo Mondo. Per questo doveva oltre che studiare le piante e gli animali usate in quelle terre come medicamenti, raccogliere le più complete informazioni dai medici, erboristi indigeni di tutti i materiali impiegati nella medicina, oggi diremmo tradizionale, effettuando su di essi anche tutte le esperienze necessarie per accertare le loro proprietà.
Hernàndez fece vela per il Messico nel settembre 1570, accompagnato dal figlio Juan e arrivò a Vera Cruz nel gennaio 1571, dopo avere sostato nel suo viaggio alla Gran Canaria, a Santo Domingo e a La Habana.
A Città del Messico, dove si stabilì, si valse della collaborazione di medici indigeni e di numerosi pittori — arte in cui i messicani erano (e sono) particolarnente abili come si deduce dai codici aztechi — per raccogliere e documentare le numerose piante descritte e allora usate nella medicina tradizionale. Dal primo anno egli potè raccogliere informazioni sulla maggior parte delle piante che poi figurano nel Tesoro. Negli anni successivi percorse varie regioni sia sull'altopiano che nel bassopiano, per constatare personalmente l'habitat e l'impiego di queste piante.
Particolare interesse presentavano tra l'altro i giardini botanici, specie quelli appartenuti ai principi della dinastia azteca. Particolarmente importanti quelli di Cuernavaca e di Huaxtepec. Ebbe anche contatti con l'eremita spagnolo Gregorio Lopez (1542-1596) che aveva raccolto numerose ricette indigene.
Durante il suo soggiorno in Messico che si protrasse fino al 1576, ebbe il modo di raccogliere e descrivere le piante secondo le nozioni botaniche dell'epoca e di classificarle secondo il metodo galenico, con saggi organolettici, stabilendo le loro proprietà, anche con pericolo personale, come quando si intossicò gravemente nell'assaggiare il latice di una euforbiacea. [...]
Hernàndez morì nel 1587 senza aver visto pubblicato il suo lavoro più importante.
Leonardo Antonio Recchi, nato a Montecorvino nell'attuale provincia di Salerno in Campania, si era addottorato in medicina nel 1564 presso la Scuola Medica salernitana. Lo troviamo in Spagna alla Corte di Filippo II quale proto-medico. Doveva avere numerose capacità se il Re gli affidò il compito di fare il compendio della relazione di Hernàndez sulle piante, animali e minerali del Messico. Questo compito fu da lui espletato durante il soggiorno in Spagna. Nel 1589 rientrò a Napoli. Morì nel 1595 in Italia, lasciando erede di tutti i suoi scritti il giureconsulto Marco Antonio Petilio.