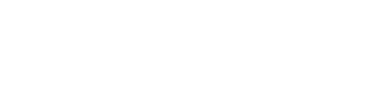La piattaforma digitale dedicata al Tesoro messicano intende mettere a disposizione degli studiosi uno strumento di consultazione e analisi del vasto repertorio botanico contenuto nel libro.
Il Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, cosiddetto Tesoro messicano, rappresenta l’esito di un lavoro avviato dall’Accademia dei Lincei intorno al 1610 e giunto a termine, a seguito di complesse vicende editoriali, soltanto nel 1651. Fortemente voluto e promosso da Federico Cesi, che vi impiegò energie e risorse straordinarie, fu portato a conclusione, dopo la sua morte (1630), da Francesco Stelluti e Cassiano dal Pozzo. Tra i principali collaboratori dell’impresa si segnalano Ioannes Schreck (Terrentius), Justus Ryckius (Iustus Riquius), Johann Faber e Fabio Colonna.
La storia dei materiali di cui l’opera si sostanzia ha inizio, in realtà, molti anni prima, nel 1570, quando Filippo II di Spagna incarica il medico Francisco Hérnandez di effettuare una ricognizione e una disamina delle risorse naturali – piante, animali e minerali – presenti nel territorio della ‘Nuova Spagna’, l’attuale Messico, che potessero risultare utili ai fini di un impiego in campo medico e farmacologico.
Le monumentali Relaciones che Hérnandez produsse al suo ritorno a Madrid, sette anni più tardi, non incontrarono il favore del sovrano. Ritenendole insoddisfacenti, il Re di Spagna incaricò allora un altro medico, Nardo Antonio Recchi (originario di Montecorvino, vicino Salerno), di selezionare e sintetizzare i risultati della ricerca. Ma neppure la rielaborazione effettuata da Recchi incontrò maggior successo: l’opera non venne, infatti, pubblicata e il suo autore fece rientro a Napoli (1589), portando con sé una copia del manoscritto, insieme alla riproduzione a colori di parte dell’apparato iconografico che corredava l’originaria opera di Hérnandez. Alla morte di Recchi, avvenuta intorno alla metà degli anni ’90, questi documenti, che a Napoli avevano già attratto l’interesse di molti studiosi, furono ereditati dal nipote, il giureconsulto Marco Antonio Petilio che, attorno al 1610, si trasferì a Roma, dove condusse anche il prezioso lascito dello zio.
Non sappiamo esattamente a quando risalga il primo incontro tra il circolo linceo e i materiali recchiani (se in occasione dei due viaggi di Cesi a Napoli, nel 1604 e nel 1610, o direttamente a Roma) né gli accordi precisi intercorsi tra il sodalizio e Petilio. Ciò che è certo, e che emerge con chiarezza sia dal carteggio che dai commenti lincei al Tesoro, è che Petilio concesse ai Lincei il permesso di copiare il manoscritto e le tabulae pictae, che conservava gelosamente presso la propria casa. Da qui prese le mosse il lavoro di studio, di commento e di integrazione portato avanti negli anni anni da diversi membri dell’Accademia. Oltre allo stesso Cesi, saranno i sodali Ioannes Schreck, Johann Faber, Fabio Colonna insieme a Justus Ryckius, Francesco Stelluti, Cassiano dal Pozzo a implementare, sviluppare, rettificare l’originaria descrizione di Recchi; a discuterla, attraverso un’operazione di confronto con la letteratura contemporanea sulle risorse naturali delle Indie occidentali; a condurre, infine, l’intera opera a compimento, pubblicandola in forma definitiva nel 1651.