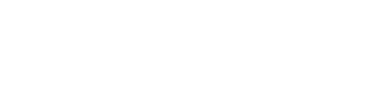La ‘filosofia’ che sottende questo lavoro nasce dalla volontà di ‘riunire in un unico spazio’ – al presente sul terreno della sola sezione botanica – quanto a una consultazione ‘fisica’ del testo cartaceo risulta distribuito e disseminato in punti diversi, spesso anche molto lontani l’uno dall’altro.
L’eccezionale apparato iconografico che Hernandez aveva fatto realizzare da artisti indigeni durante la sua spedizione in Messico (originali perduti durante l’incendio della Biblioteca dell’Escorial del 1671) venne parzialmente riprodotto da Recchi in occasione del suo compendio. A tale riproduzione avevano a loro volta attinto i Lincei per eseguire le copie da utilizzare nella stampa del Tesoro (cfr. Faber, Alia animalia novae hispaniae, p. 788).
La resa delle immagini, ottenute (a costi elevatissimi) attraverso la tecnica xilografica, non fu – come apparve subito evidente a Cesi e ai sodali lincei – propriamente soddisfacente, soprattutto se paragonata alle eccellenti riproduzioni che figuravano in testi botanici coevi, come l’Hortus Eystettensis di Basilius Besler (1613). Alla scarsa definizione dei contorni e dei dettagli si aggiungeva l’assenza, nella stampa, dei colori, ben presenti nella copia di Recchi. Appariva così di fondamentale importanza, per i commentatori lincei, sopperire a questa evidente lacuna col fornire precise indicazioni e informazioni circa l’aspetto degli esemplari provenienti dal Nuovo mondo, restituendone – attraverso il ricorso a similitudini con oggetti appartenenti al Vecchio – odori, sapori, sensazioni tattili di vario genere. Una necessità tutt’altro che trascurabile in particolare per la sezione botanica – in assoluto la più consistente: circa 830 immagini, se comprendiamo i particolari singolarmente raffigurati – dove occorreva incoraggiare il lettore a procedere oltre l’impressione fornita dalla ‘nuda figura’ in bianco e nero, affiancandole, ove possibile, una puntuale ‘colorum descriptio’ delle sue varie componenti: fiori, semi, foglie, radici, ecc. (cfr. Schreck, Aliarum novae hispaniae plantarum, p. 346).
La resa delle immagini, ottenute (a costi elevatissimi) attraverso la tecnica xilografica, non fu – come apparve subito evidente a Cesi e ai sodali lincei – propriamente soddisfacente, soprattutto se paragonata alle eccellenti riproduzioni che figuravano in testi botanici coevi, come l’Hortus Eystettensis di Basilius Besler (1613). Alla scarsa definizione dei contorni e dei dettagli si aggiungeva l’assenza, nella stampa, dei colori, ben presenti nella copia di Recchi. Appariva così di fondamentale importanza, per i commentatori lincei, sopperire a questa evidente lacuna col fornire precise indicazioni e informazioni circa l’aspetto degli esemplari provenienti dal Nuovo mondo, restituendone – attraverso il ricorso a similitudini con oggetti appartenenti al Vecchio – odori, sapori, sensazioni tattili di vario genere. Una necessità tutt’altro che trascurabile in particolare per la sezione botanica – in assoluto la più consistente: circa 830 immagini, se comprendiamo i particolari singolarmente raffigurati – dove occorreva incoraggiare il lettore a procedere oltre l’impressione fornita dalla ‘nuda figura’ in bianco e nero, affiancandole, ove possibile, una puntuale ‘colorum descriptio’ delle sue varie componenti: fiori, semi, foglie, radici, ecc. (cfr. Schreck, Aliarum novae hispaniae plantarum, p. 346).
Utilizzando, quindi, come ‘unità’ le singole immagini distribuite all’interno dei capitoli dei vari libri, di cui si mantiene l’esatta scansione (libro 2, 3 ecc., fino all’8), si è così proceduto a integrare l’originario commento di Schreck apposto al testo di Recchi con tutti gli interventi successivi dispersi in luoghi differenti dell’opera – dalle Aliae plantae alle Notes omissae nonnullae - unendo a questi, quando presenti, le stesse annotazioni di Colonna in modo che il lettore abbia di fronte a sé, in un unico spazio, nell’ordine: l’immagine della pianta, il riferimento immediato all’originaria descrizione del testo di Recchi tramite collegamento diretto all’opera (Vai al testo); il commento integrato di Schreck/Colonna come pure i rimandi relativi alla medesima (o omonima) pianta in luoghi diversi del testo.
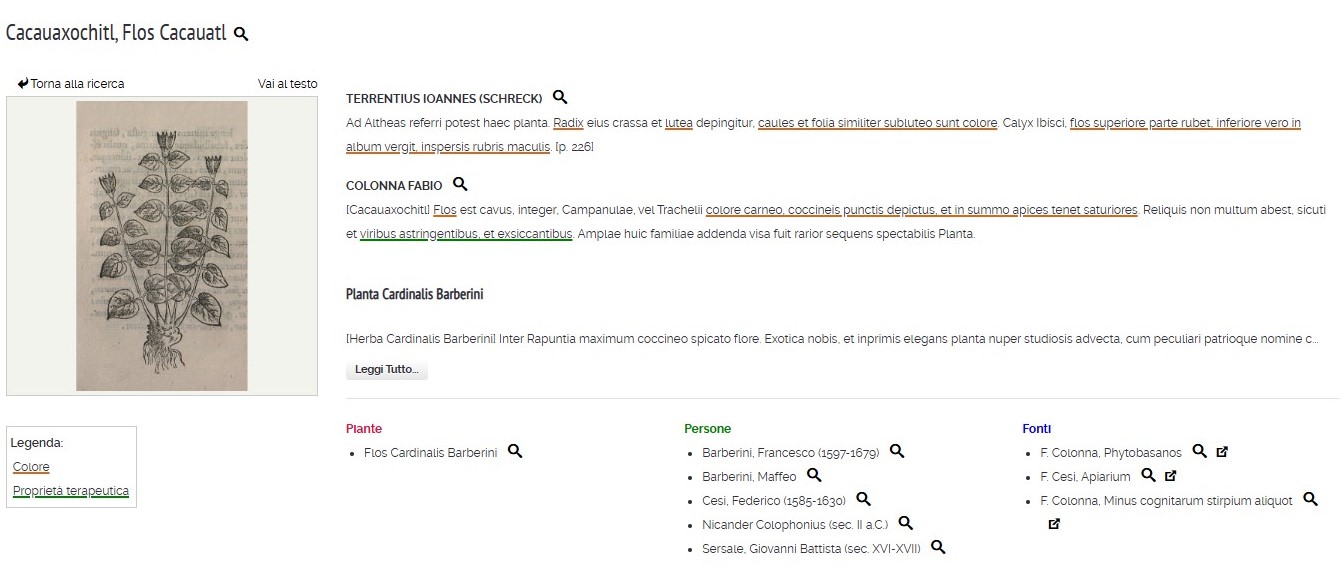
I commenti dei due lincei divengono in questo modo la chiave per un confronto con la letteratura botanica precedente o coeva (da Prospero Alpino a Monardes, Clusius, Da Orta ecc.) opportunamente richiamata attraverso tag a testi e autori.
Non è stato possibile, in questa prima fase del lavoro, corredare di adeguati commenti di carattere storico-artistico o scientifico (di tipo botanico, farmacologico, chimico-alchemico) la presentazone della ricca rassegna offerta dal Tesoro. Si sono però, per ogni esemplare, evidenziati colori e proprietà terapeutiche (‘Legenda’), al fine di fornire una base iniziale per futuri, specifici approfondimenti.